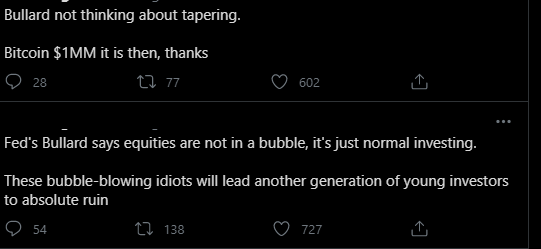Oggi Recce’d pubblica sei nuovi Post. Il lancio della nuova impostazione di questo Blog (a temi, e con un nuovo layout) è stato rinviato al secondo trimestre 2021 in ragione della rapidissima evoluzione della situazione dei mercati finanziari nel mese di gennaio. Per noi di Recce’d, sono sempre i mercati a dettare i tempi. In aggiunta, oggi le occasioni per gli investitori sono le più grandi di una generazione. e noi di certo non vogliamo perderle di vista.
Dietro ad ogni nostro atto, si nasconde sempre una teoria.
Anche se non ce ne rendiamo conto, facciamo sempre riferimento ad una teoria, ad uno schema logico, ad una elaborazione della mente, prima di compire ogni piccolo gesto.
Perchè ci è necessario immaginare le conseguenze del nostro gesto: ed in quel momento, ci diventa necessario generalizzare, passare dal particolare del nostro atto al generale di una teorizzazione.
Tutto questo è tanto più vero nell’ambito della finanza e degli investimenti: ed anche se moltissimi (la grandissima parte) degli investitori non se ne rende conto, ciò che accade ogni giorno sui mercati finanziari va (solo per una parte, ma non piccola) attribuito alle teorie di Smith, di Fisher, di Ricardo, di Sharpe, di Tobin, di Fama, e degli altri studiosi che in questo Blog sono stati richiamati alla vostra attenzione centinaia di occasioni.
Dell’ultimo anno, non si può non sottolineare il ritorno di Keynes, economista britannico degli Anni Trenta del secolo scorso.
Non ci proponiamo in questo Post di approfondire sul pensiero economico di Keynes. ci saranno altre sedi ed altre occasioni. Il lettore interessato ci può contattare con le modalità già note.
Ci limiteremo qui a toccare l’argomento Keynes con riferimento alla strettissima attualità: il Recovery Fund europeo, ed il Piano Biden degli Stati Uniti.
Come abbiamo scritto, in modo più dettagliato, nel nostro The Morning Brief per le ultime due settimane, tutto il Mondo si è “italianizzato”.
Quelli che per decenni sono stati gli indicatori del “problema Italia” (elevato deficit e debito pubblico, cronica disoccupazione, ritmi di crescita vicini allo zero) negli ultimi 12 mesi sono stati “sdoganati” nel senso che … non sono più un problema.
Nel Mondo, si riconcorrono gli appelli agli Stati: “spendete di più”. E questa volta, sui mercati finanziari, tutti o quasi fanno festa.
Dietro c’è per l’appunto la teoria di Keynes, alla quale si attribuisce la fuoriuscita dalla profonda depressione economica degli anni Venti e Trenta del secolo scorso.
Senza avere la pretesa di smentire Keynes e criticare la sua teoria, ci sentiamo però di affermare che la crisi del nuovo Millennio ha poco in comune con quella del 1929 ed anni seguenti, E che se le cause sono diverse, anche i rimedi probabilmente dovrebbero essere differenti.
La sola similitudine fondata, a nostro giudizio, è quella che si rifà alla Germania di Weimar.
Per il resto, si tratta di situazioni del tutto differenti, e questo dovrebbe risultarvi ovvio anche soltanto se pensate al fatto che sono trascorsi 100 anni di storia.
Allo scopo di aiutarvi a ricostruire ciò che è successo, e ciò che è cambiato, negli ultimi 100 anni, a proposito delle politiche economiche (monetarie e fiscali) per combattere le crisi, dei loro successi e dei loro insuccessi, abbiamo trovato un utilissimo articolo del Financial Times, che vi proponiamo qui in lettura.
Lettura dalla quale risulta evidente una certa “ciclicità” che interessa le teorie economiche dominanti. In ragione della quale, noi ci sentiamo di ripetere che anche se oggi è “di moda” Keynes, per noi investitori guardando al futuro è più utile rileggere Wicksell.
I temi affrontati da Keynes, oggi, risultano più “spendibili” nel contesto politico rispetto a quelli di Wicksell: fanno contenti tutto, o quasi.
Ma per i nostri portafogli di investimento è necessario guardare OGGI alle conseguenze che si vedranno DOMANI.
Recce’d ogni giorno approfondisce questi temi in The Morning Brief. data la particolare importanza di questi temi, li riprenderemo anche nel Blog. E ovviamente per approfondire ci potete anche contattare.
The other week I caught sight of a headline declaring that the IMF was warning against cuts in public spending and borrowing. The report stopped me in my tracks. After half a century or so as keeper of the sacred flame of fiscal prudence, the IMF was telling policymakers in rich industrial nations they should not fret overmuch about huge build-ups of public debt during the Covid-19 crisis. John Maynard Keynes had been disinterred, and the world turned upside down.
To be clear, there is nothing irresponsible about the IMF’s advice that policymakers in advanced economies should prioritise a restoration of growth after the deflationary shock of the pandemic. The fund prefaced a shift last year, and most people would say it was common sense to allow economic recovery to take hold. Nations such as Britain might have learned that lesson from the damage inflicted by the ill-judged austerity programme imposed by David Cameron’s government after the 2008 financial crash.
And yet. This was the IMF speaking — the hallowed (for some, hated) institution that, as many Brits will recall, formally read the rites over Keynesianism when in 1976 it forced James Callaghan’s Labour government to impose politically calamitous cuts in spending and borrowing. This is the organisation that in the intervening years had a few simple answers to any economic problem you care to think of: fiscal retrenchment, a smaller state and/or market liberalisation. The advice was heralded as the Washington consensus because of the IMF’s location.
My first job after joining the Financial Times during the early 1980s was to learn the language of the new economic orthodoxy. Kindly officials at the UK Treasury explained to me that the technique of using fiscal policy to manage demand, put to rest in 1976, had been replaced by a new theory. Monetarism decreed that as long as the authorities kept control of the money supply, and thus inflation, everything would be fine. The snag was that every time the Treasury alighted on a particular measure of the money supply to target — sterling M3, PSL2, and M0 come in mind — it ceased to be a reliable guide to price changes. Goodhart’s law, this was called, after the eponymous economist Charles.
By the end of the 1980s, monetarism had been ditched, and targeting the exchange rate had become the holy grail. If sterling’s rate was fixed against the Deutschmark, the UK would import stability from Germany. It was about this time that a senior aide to the chancellor took me to one side to explain that one of the great skills of the Treasury was to perform perfect U-turns while persuading the world it had deviated not a jot from previous policy. This proved its worth again when the exchange rate policy was blown up by sterling’s ejection from the European exchange rate mechanism in 1992. The currency was quickly replaced by an inflation target as an infallible lodestar of policy. The eternal truths amid the missteps and swerves were that public spending and borrowing were bad, tax cuts were good, and market liberalisation was the route to sunlit uplands.
The pound’s ERM debacle was followed by a ferocious budgetary squeeze, and, across the channel, the eurozone was designed to fit a fiscal straitjacket. Financial market deregulation, we were told, oiled the wheels of globalisation. If madcap profits and bonuses at big financial institutions prompted unease, the answer was that markets would self-correct. Britain’s Labour government backed “light-touch” regulation in the 2000s. The Bank of England reduced its oversight of systemic financial stability. The abiding sin threaded through it all was that of certitude. Perfectly plausible but untested theories, whether about the money supply, fiscal balances and debt levels, or market risk, were elevated to the level of irrefutable facts.
Economics, essentially a faith-based discipline, represented itself as a hard science. The real world was reduced by the 1990s to a set of complex mathematical equations that no one, least of all democratically elected politicians, dared challenge. Thus detached from reality, economic policy swept away the postwar balance between the interests of society and markets. Arid econometrics replaced a measured understanding of political economy. It scarcely mattered that the gains of globalisation were scooped up by the super-rich, that markets became casinos and that fiscal fundamentalism was widening social divisions. Nothing counted above the equations.
And now? After Donald Trump, Brexit and Covid-19, it seems we are back at the beginning. Time to dust off Keynes’s general theory.