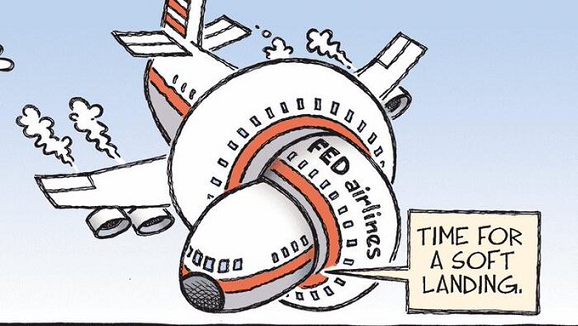La "doppia percezione": si vuole "tenere tutto fermo" proprio perché tutto si muove
E’ in corso il meeting a Cernobbio, e fino a questo momento la copertura dei media italiani è stata decisamente inferiore a ciò che di solito siamo abituati a vedere: il numero di servizi nei TG e di articoli in prima pagina è decisamente inferiore alla media.
Come si spiega?
Può darsi che ci siano meno cosa de dire e da discutere.
Oppure, questo tipo di “eventi” ha cominciato a venire a noia: in effetti, il clamore mediatico da sempre è di molte volte superiore ai contenuti del meeting. Si potrebbe anzi affermare che, nel corso di eventi di questo tipo, i partecipanti si sentano in dovere di dire il meno possibile, riservando gli interventi significativi ad altre sedi.
Oppure (terza ipotesi) la questa scarsa attenzione dei media corrisponde una generale tranquillità: si dice poco perché c’è poco da dire. Tutto è tranquillo, all’orizzonte, e non ci sono difficoltà da affrontare con urgenza.
Recce’d lascia ai suoi lettori il compito di risolvere questo dubbio. Al tempo stesso, con questo Post noi ci proponiamo di aiutare concretamente i lettori interessati a trovare la risposta giusta.
Partiamo proprio dalla nostra amata Italia: è corretto guardare al futuro (anche immediato) della nostra economia come se all’orizzonte non ci fosse alcun serio ed urgente problema da risolvere? E’ corretto presentare l’attuale situazione dell’Italia come se l’Italia fosse un’economia tutto sommato stabile? Si può dire che il solo, grande problema sia il rapporto con l’Unione Europea, e quindi i fondi che arrivano con il Pnrr e poi il Patto di Stabilità?
Leggendo il resoconto giornalistico che segue, si ricava proprio questa impressione.
CERNOBBIO — Per il nuovo Patto di stabilità probabilmente è meglio aggiornarsi all’anno prossimo, per evitare “esercizi provvisori” e partire finalmente nel 2025 con un Patto nuovo e definitivo, concordato con calma e stavolta davvero granitico.
Tecnicamente non è impossibile rivedere con un atto politico comune — così come un atto politico è stata la sospensione per il periodo pandemico — la decisione di reinstallare automaticamente il “vecchio” Patto con tutto il suo carico di penalizzazioni per il nostro Paese, al quale farebbe seguito l’anno dopo il nuovo Patto: più semplice prorogare ancora di un anno la sospensione.
È questa la posizione espressa un po’ a sorpresa da alcuni degli economisti, imprenditori e manager riuniti a Cernobbio per il Forum Ambrosetti.
La situazione spagnola
«Troppo complicato è a questo punto impostare la necessaria svolta perché questo diventi veramente un Patto di crescita, per prima cosa, e poi di stabilità che è una derivata della crescita», dice Vincenzo Boccia, imprenditore nel settore della stampa, già presidente della Confindustria e oggi a capo della Luiss.
«C’è un problema politico connesso con la complessa situazione spagnola: se continua l’attuale incertezza e non si riesce a formare un governo, è difficile che Madrid nel suo semestre di presidenza, che scade il 31 dicembre, riesca a risolvere un problema così complesso», aggiunge Enrico Giovannini, più volte ministro, ordinario di Statistica economica a Tor Vergata.
La presidenza belga
«Il prossimo semestre sarà presieduto dal Belgio, Paese più o meno benigno nei nostri confronti come la Spagna, con una storia di debito pesante dal quale però è vero che si sono riscattati», riflette Brunello Rosa, docente alla London School of Economics e alla Bocconi.
«Insomma — aggiunge Rosa — potrebbe essere tentato di darci qualche lezione. In più c’è l’incognita della prossima Commissione, che sarà nominata dopo le elezioni europee di primavera e potrebbe essere espressione di una maggioranza di forze conservatrici tradizionalmente ostili all’Italia».
Ma quello che toglierà davvero tempo, dice a sua volta l’imprenditore Riccardo Illy, «sarà la determinazione delle cifre di cui non tener conto ai fini del debito/Pil. Sicuramente andranno inseriti fra queste gli investimenti per il miglioramento energetico».
Le regole fiscali
In ogni caso «non c’è dubbio che occorrano regole fiscali condivise — sintetizza Alessandro Terzulli, capo economista della Sace che presenterà oggi al Forum uno studio su Pmi e export — e che quelle in vigore prima della pandemia siano da cambiare».
Il negoziato (si riprende all’Ecofin fra due settimane) è bloccato su due posizioni. Una, alla quale aderisce (senza troppa convinzione) l’Italia, prevede che per il rapporto debito/Pil si intraprenda un negoziato one-on-one con la Commissione per stabilire piani di rientro “personalizzati”.
La paura del governo è che la Commissione acquisisca troppo potere a danno dal sacro sovranismo. La seconda posizione è quella classica tedesca, con cifre e percentuali prefissate e uguali per tutti (magari un po’ meno rigide che in passato) che offrano un riferimento preciso e ineludibile.
Gli sbilanci macroeconomici
«Ma i livelli di debito sono diventati così diversificati, e in grado davvero se mal gestiti di determinare sbilanci macroeconomici che coinvolgerebbero l’intera Eurozona, che è davvero difficile pensare a un parametro unico», obietta Rosa.
Per Giovannini l’urgenza è un’altra: «Qualsiasi sia la formula scelta, bisogna che la Commissione si metta in grado, e inserisca le modalità nel nuovo patto, di prevenire le conseguenze di eventi violenti e prolungati come la pandemia e la guerra, di fronte alle quali pur con importanti successi si è trovata spesso in difficoltà».
Giovannini, che è portavoce dell’Associazione per lo sviluppo sostenibile, puntualizza che già nei trattati formativi dell’Ue si parlava di “deducibilità fiscale” per terremoti o alluvioni, «ma ora bisogna assolutamente aggiungere gli interventi sul dissesto idrogeologico e la mitigazione di tutti gli altri disastri ambientali: costa meno che intervenire a tragedia compiuta».
La questione, per noi investitori, che tutti abbiamo nel nostro portafoglio titoli posizioni su asset italiani, non si tratta di una questione marginale. Al contrario, è decisivo capire se è questa una rappresentazione corretta dello stato attuale dell’economia e della finanza in Italia, oppure se questo tipo di resoconti fa parte di un dibattito di tipo politico.
Un dibattito politico che si svolge a lato dell’evoluzione della realtà: della realtà dell’economia e della realtà della finanza nazionale.
Su questo si è espresso, in una intervista a La Repubblica, Mohamed El Erian.
CERNOBBIO — «L’Italia rischia grosso nell’attuale momento di sbandamento di alcune delle economie per lei più importanti. È più che mai necessario che trovi al suo interno le forze, la coerenza e la capacità progettuale per risollevarsi». Mohamed El-Erian, presidente del Queen’s College di Cambridge («quello in Inghilterra, l’unico Cambridge che esiste», scherza), conosce bene l’economia del nostro Paese («questo è il mio decimo Cernobbio»). Dalle sue parole traspare un misto di paura e speranza quando gli leggiamo il dato negativo sul Pil: -0,4% nel secondo trimestre, peggio del -0,3% valutato inizialmente dall’Istat.
Questo brusco arretramento del Pil si affianca alla crescita zero della Germania, che peraltro ha conosciuto già una lieve recessione quest’inverno. Cattivi segnali?
«Pessimi. La Germania paga per l’eccessiva dipendenza dall’energia russa, e ora per la debacle cinese. Ecco, se dovessi stilare una classifica partendo dal basso delle economie mondiali partirei dalla Cina, in condizioni davvero precarie, poi la Germania, quindi l’Eurozona per cui la Germania è l’economia-guida, e al vertice l’America che è riuscita a evitare la recessione, non solo ma sta progredendo. L’accelerazione dell’America è una delle poche grandi sorprese positive in questo momento».
L’Europa riuscirà nella stessa operazione?
«Non è sicuro. I serrati rialzi imposti dalla Bce devono ancora dispiegare tutti i loro effetti, positivi ma specialmente negativi. Purtroppo i mali della locomotiva tedesca si riverberano a catena. La locomotiva sta marciando all’indietro: la buona sorpresa è semmai che ancora non ha trascinato in basso tutti gli altri».
Cosa deve fare l’Italia per schivare questa minaccia?
«Una cosa è certa: l’Italia è sensibile a quanto succede sia in Cina che in Germania, molto di più di quanto non sia sensibile a quello che succede negli Stati Uniti. Un’altra certezza è che deve farcela con le sue forze, che non sono poche, anzi, ma sicuramente sottoutilizzate. Ci sono pochi Paesi così intrinsecamente ricchi come l’Italia, con la sua industria e non dimentichiamoci con il turismo che è una permanente macchina da soldi. Potrebbe fare molto di più: mi dà l’impressione invece di una macchina da corsa che va sempre con la seconda ingranata e non riesce ad alzare la marcia».
Rischia di essere trainata verso il basso?
«Esatto. Pensate a Paesi che sono diventati esempi di successo senza nessuna risorsa iniziale, come Singapore dove tutto è dovuto alla buona gestione. Così l’Italia: il suo salto di qualità è funzione di quello che riuscirà a fare il governo, che deve assumere un ruolo trainante nell’impostare gli investimenti privati, interni e provenienti dall’estero, in favore dei settori più avanzati in grado di guidare la modernizzazione le cui basi peraltro già possiede: hi-tech, meccanica strumentale avanzata, intelligenza artificiale, fonti energetiche sostenibili».
Questo “traino” dovrà avvenire con incentivi?
«Anche, affiancati però da politiche ben finalizzate e infrastrutture adeguate. Il tutto deve incentivare la produttività, dopodiché i risultati saranno esponenziali. Gli Stati Uniti hanno imbracciato decisamente quest’esigenza con particolare riferimento alla sostenibilità, e hanno varato l’Inflation Reduction Act. I risultati già si vedono».
L’Europa con il NextGenEU ha lanciato un programma analogo.
“Ma sul suo successo grava l’incertezza applicativa in alcuni Paesi primo fra tutti l’Italia, e poi l’incompleta realizzazione dell’Europa. È come una sedia con quattro gambe: l’unione monetaria, l’unione fiscale (nel senso anglosassone di convergenza delle politiche di bilancio, ndr), l’unione bancaria, un processo comune di “decision making”. Solo la prima di queste gambe è solida: e la sedia così non si può reggere».
Come avete appena letto, Mohamed El Eria esprime una visione decisamente diversa da quella che era presentata nel precedente articolo. Non esiste solo il Patto di Stabilità.
Non solo questa visione di El Erian è decisamente meno centrata sull’Europa, e meno centrata sulla politica nazionale, ma si intravede anche un livello più elevato di fragilità.
Dove nel primo intervento si vedeva una situazione “tutto sotto controllo, nessuna emergenza, servono solo pochi ritocchi politici”. Qui si legge invece di una situazione fragile, che rapidamente potrebbe andare al “fuori controllo”.
Come già detto, lasciamo a chi ci legge di scegliere quale posizione assumere nel proprio portafoglio titoli: noi di Recce’d sui portafogli modello le scelte le abbiamo fatte, e a tempo debito, che vuole dire MOLTI mesi fa, quando in effetti dovevano essere fatte.
Oggi, è comunque tardi.
Per chiudere il Post, però, vogliamo uscire allo scoperto: non vogliamo nasconderci, e prendiamo una posizione in pubblico. Così che i nostri lettori possano, tra tre mesi, tra sei mesi, tra dodici mesi, ripresentarci questo Post e chiederne conto.
Non è una novità: Recce’d da sempre si espone a questo tipo di verifiche ex-Post: ad esempio, con grande regolarità noi mettiamo a confronto i risultati ottenuti dai portafogli modello e quindi dai nostri Clienti con quelli dei Fondi Comuni Flessibili, dei Fondi Comuni Bilanciati, di tutte le GPM che sono offerte ai risparmiatori in Italia, ma pure con quelle del Fondi di tipo Hedge.
In questo momento, ognuno di questi confronti per noi è favorevole: ma se anche in futuro non fosse favorevole, noi continueremo a fare questo raffronto come minimo una volta al mese ed ogni volta che è necessario.
Torniamo però al tema del Post, e (come scritto sopra) prendiamo una posizione.
Lo facciamo utilizzando il lavoro di un notissimo giornalista italiano, Ferruccio De Bortoli, che ha voluto questa settimana sottolineare sul proprio quotidiano (Corriere della Sera) il grande numero di argomenti che vengono, in questo momento, trascurati dalla massa degli investitori.
Come le sue parole, De Bortoli si colloca più vicino ad El Erian qui sopra, piuttosto che all’atteggiamento di chi è stato intervistato nel primo articolo di questo Post.
Trovate più sotto le nostre considerazioni conclusive.
Uno dei temi più appassionanti, e per certi versi inquietanti, di questa ripresa riguarda la doppia percezione dei fenomeni globali. Non solo a livello di opinione pubblica ma anche e soprattutto da parte dei grandi gestori di fondi che hanno a che fare poi con i nostri risparmi.
La domanda di fondo è la seguente: si può pensare realmente che la perdita di peso specifico globale delle democrazie e delle economie di mercato non abbia in prospettiva un impatto rilevante sul benessere reale di una parte del mondo in affanno se non in ritirata?
Sul piano geopolitico l’allarme è elevato. Al di là di una guerra alle porte dell’Europa che continua e della quale ci si interessa sempre meno, nonostante un andamento tutt’altro che favorevole per Kyiv, destano forti timori le tensioni crescenti nel Pacifico e le preoccupazioni sull’accerchiamento cinese di Taiwan. Pechino, nonostante le frenata della propria economia, è poi capofila della nuova stagione, allargata potenzialmente ad altri sei Paesi, dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa).
Al contrario, sul versante più strettamente finanziario e dell’andamento dei mercati sembra solo una questione di inflazione troppo alta e di tassi d’interesse. Lo testimoniano i lavori del tradizionale incontro dei governatori centrali a Jackson Hole.
Economie di mercato che hanno subito ben due choc imprevisti (la pandemia e la guerra), sembrano volersi concentrare unicamente sulle questioni di crescita e di transizione energetica e digitale, quasi a esorcizzare pericoli di altra natura che però non sono del tutto scomparsi, per esempio una guerra tra valute e il debito, soprattutto dopo l’esplosione della bolla immobiliare cinese con le difficoltà di Evergrande — che ha chiesto la protezione dai creditori negli Stati Uniti -—e Country Garden.
Ma l’alto livello di indebitamento pubblico e privato non costituisce per il momento un’emergenza generale. Anzi, c’è un discreto consenso sul fatto che la lotta al riscaldamento climatico richiederà nuovi debiti, sottovalutando forse la loro sostenibilità per alcuni Paesi (Italia compresa). Ricapitolando, da una parte vi è la preoccupazione crescente per gli equilibri strategici e per la relativa perdita di peso dei Paesi del G7 di fronte al dinamismo del cosiddetto Global South, per l’allargamento del fronte dei Brics che attenua l’isolamento internazionale di Putin e accresce la leadership cinese.
La minaccia fantasma al dollaro
Ma se la frammentazione politica inquieta, quella economica e finanziaria lo fa assai meno. La minaccia di sostituire il dollaro in alcune delle transazioni che interessano le materie prime energetiche e rare, in gran parte dominio dei regimi autoritari, è stata poco più che una boutade, ma nasconde comunque l’intenzione politica, che non andrebbe sottovalutata, di essere meno dipendenti dal dollaro. Con l’annunciato, ma non sicuro, ingresso nei Brics (come si chiameranno?) di Arabia Saudita, Emirati, Iran, Argentina, Egitto ed Etiopia, la nuova coalizione varrebbe il 36 per cento del prodotto interno lordo mondiale.
Lo scetticismo espresso da Ian Bremmer sul Corriere è condiviso dallo stesso inventore dell’acronimo Brics, Jim O’ Neill, che lo coniò all’inizio del secolo quando lavorava per Goldman Sachs. Ma è indubbio che sia in atto un movimento politico, confuso e contraddittorio finché si vuole, ma certamente alternativo e critico con l’Occidente, gli Stati Uniti e l’Europa. Difficile ritenere che tutto ciò non abbia ripercussioni di qualche natura anche sul mercato dei capitali. Eppure i grandi gestori non appaiono per nulla preoccupati. Forse perché la capacità di reazione agli choc è stata superiore a ogni più rosea previsione.
La risposta dell’industria farmaceutica occidentale al Covid è stata incomparabilmente più efficace di quella cinese o russa. Nessuno immaginava che l’Europa, e segnatamente l’Italia, potessero liberarsi così presto dal ricatto energetico russo. E ancora nessuno prevedeva che la penuria dei chip, dei semiconduttori, che l’Occidente non produceva da tempo, si trasformasse in così poco tempo, in una potenziale abbondanza d’offerta, grazie anche alla minore attività di mining, la dispendiosa, soprattutto sotto il profilo energetico, attività di creazione di criptovalute. Danilo Taino sul Corriere ha spiegato con chiarezza come periodicamente l’idea di sostituire il dollaro faccia capolino in stati che vogliono contrapporsi o distinguersi ancora di più dal potere occidentale e americano.
La svolta brasiliana
La svolta di Lula è per certi versi clamorosa, soprattutto nell’avvicinamento a Putin. Tra l’altro, a dimostrazione della relativa compostezza del fronte dei Brics allargato, si segnala che i maggiori disinvestimenti in titoli cinesi, per il timore di un effetto domino, sono avvenuti proprio dai partner vecchi e nuovi di questo gruppo del Global South. È vero che il peso del dollaro negli scambi internazionali è diminuito secondo i dati del Fondo monetario. Le riserve mondiali erano al 79% in dollari nel 1999, sono scese al 59%o nel 2022.
La corsa tecnologica dei Brics
Gli Stati Uniti hanno congelato, dopo l’inizio della guerra in Ucraina, metà delle riserve valutarie russe in dollari. E altrettanto hanno fatto con altri Paesi sotto sanzioni, come l’Iran. Ritorsioni politiche che saranno sempre più difficilmente attuabili, in altre condizioni. Non certamente contro la Cina che continuava a possedere, a fine dicembre 2022, seppur in discesa rispetto al massimo del 2010, circa 860 miliardi di titoli del debito pubblico americano. «Sull’importanza crescente dei Brics conservo qualche nota di scetticismo — dice il filoso e analista geopolitico Alessandro Aresu, autore de Il dominio del XXI secolo, edito da Feltrinelli — sono soprattutto una potenza demografica. L’India di Modi, che ha appena conquistato il polo sud della Luna e tra l’altro registra lo spostamento rilevante di una parte di produzione di Apple dalla Cina, la cui economia è in vistoso rallentamento, non è in sintonia politica, religiosa con gli altri partner.
Le differenze di varia natura sono rilevanti. Però è vero che il G7 è sempre meno rappresentativo degli equilibri mondiali e questa frammentazione si rifletterà inevitabilmente sugli obiettivi di decarbonizzazione e sul rischio di dipendenza dalla Cina per alcune tecnologie essenziali nella transizione, come l’elettrico e il solare. Ma negli ultimi tempi si è notato un discreto spostamento di produzioni manifatturiere da Pechino verso la Thailandia, il Vietnam e l’Indonesia, il cui peso nell’economia mondiale è cresciuto ben oltre quello di alcuni membri dei Brics».
Il dollaro e la nuova guerra delle valute
«Ciò che mi colpisce — commenta Ernesto Paolillo che è stato a lungo presidente del Forex, cioè degli operatori su valute e cambi — è notare come grandi gestori di asset management, banche commerciali, istituzioni che investono molto nella ricerca, nell’era dell’intelligenza artificiale, trascurino del tutto i pericoli che possono derivare, nel campo delle valute, da una nuova fase della conflittualità mondiale. Eppure negli ultimi tempi abbiamo assistito alla svalutazione della moneta cinese, per non parlare del rublo che conta poco, il dollaro appare sovrappesato rispetto all’euro. Le coperture sui rischi di cambio sono pressoché inesistenti. E oggi i derivati per proteggersi costano poco, anche per la modesta volatilità dei mercati. Una situazione che però non è destinata a durare nel tempo».
Come sapete bene, il lavoro di Recce’d per i suoi lettori, ma soprattutto verso i nostri Clienti, NON è quello di “informare”.
Recce’d NON fa “informazione”, come invece fanno i tre articoli che avete appena letto.
Recce’d per mestiere utilizza i tre articoli, e migliaia di altre informazioni, per ottenere dai propri modello una performance eccellente (nel confronto con tutti le possibili alternative di investimento disponibili) a rischio rigidamente controllato (in termini di oscillazione del valore del portafoglio e di minusvalenze).
I tre articoli che avete appena letto, da questo punto di vista, sono ricchissimi di spunti, che devono poi essere tradotti da Recce’d (ed anche da voi lettori di Recce’d) in pratica operativa, ovvero in scelte di portafoglio.
In questo specifico momento, le nostre scelte operative:
danno poca importanza a quanto viene detto nel primo dei tre articoli
attribuiscono maggiore importanza invece a ciò che dice El Erian nel secondo articolo
e danno infine GRANDE importanza a ciò che ha scritto De Bortoli
Questo (chiariamo subito) NON significa che ciò che De Bortoli scrive noi abbiamo fatto: non è così. Noi abbiamo invece UTILIZZATO ciò che De Bortoli scrive (insieme con altri elementi di valutazione) per confermare oppure modificare le scelte per i portafogli modello di Recce’d.
In particolare, abbiamo utilizzato questi passaggi che mettiamo per voi lettori in evidenza:
La domanda di fondo è la seguente: si può pensare realmente che la perdita di peso specifico globale delle democrazie e delle economie di mercato non abbia in prospettiva un impatto rilevante sul benessere reale di una parte del mondo in affanno se non in ritirata?
Economie di mercato che hanno subito ben due choc imprevisti (la pandemia e la guerra), sembrano volersi concentrare unicamente sulle questioni di crescita e di transizione energetica e digitale, quasi a esorcizzare pericoli di altra natura che però non sono del tutto scomparsi, per esempio una guerra tra valute e il debito
Ma è indubbio che sia in atto un movimento politico, confuso e contraddittorio finché si vuole, ma certamente alternativo e critico con l’Occidente, gli Stati Uniti e l’Europa. Difficile ritenere che tutto ciò non abbia ripercussioni di qualche natura anche sul mercato dei capitali.
notare come grandi gestori di asset management, banche commerciali, istituzioni che investono molto nella ricerca, nell’era dell’intelligenza artificiale, trascurino del tutto i pericoli che possono derivare, nel campo delle valute, da una nuova fase della conflittualità mondiale
E voi, amici lettori, che cosa giudicate rilevante, per la vostra attuale posizione del portafoglio titoli? Che posizione avete preso, su temi come questi?